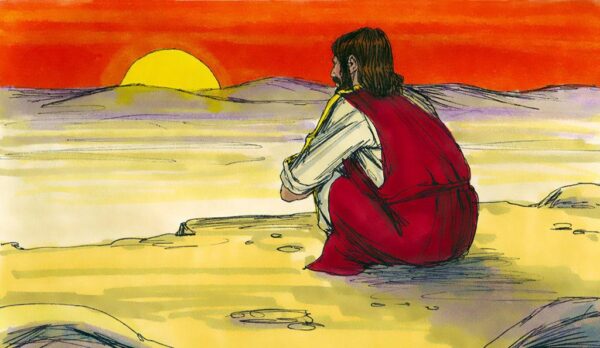Comunicato stampa Roma 21 Febbraio 2026 – Cardinal Ruini rivela di essersi innamorato 3 o 4 volte… ma ancora per lui tabù preti sposati e riammissione al ministero
Il Movimento Internazionale commenta intervista a Ruini: “Nostalgiche dichiarazioni che non incidono nella vita di oggi della Chiesa bisognosa di riforme per arginare la crisi dei preti. I preti sposati sono una grande ricchezza per la Chiesa”
Di seguito l’intervista del Corriere della Sera
Cardinal Ruini, oggi sono 95 anni. Qual è il segreto della longevità?
«Non saprei. Forse, in ordine di importanza crescente: una vita ordinata; il Dna di ciascuno; la misura del dono di Dio».
Lei cosa mangia, cosa beve? Ha fatto esercizio fisico?
«Seguo più o meno una dieta mediterranea: pasta, verdure, carne, frutta; niente di particolare. Bevo acqua. E faccio da molti anni tanta fisioterapia».
Quanto conta la fede? Quanto la curiosità intellettuale per il mondo?
«Fede e durata della vita terrena sono due grandezze indipendenti l’una dall’altra: pensi alla morte precoce di Carlo Acutis. La curiosità intellettuale può aiutare a tenere vivo il cervello, e così forse allungare la vita».
Qual è il suo primo ricordo?
«Un prato in collina, e la mia palla che ruzzolando finisce contro un filo spinato e si buca. Era l’estate del 1934, avevo tre anni».
Com’era l’Italia fascista?
«Un’Italia che non mi piaceva. Troppo sicura di sé e inconsapevole delle sue debolezze».
È vero che lei ebbe una discussione con suo padre sulla guerra?
«Ne avevo spesso. Mio padre era convinto che la guerra l’avremmo vinta. Io invece che l’avremmo perduta».
Perché?
«Perché avevo appreso dal libro di geografia per le scuole medie che i nostri avversari erano molto più ricchi di noi».
Della guerra cosa ricorda?
«I bombardamenti, che non risparmiarono il mio paese, Sassuolo. La morte di alcuni amici. Il lungo periodo trascorso come sfollato nella casa di campagna di mio padre. Un periodo, quest’ultimo, molto positivo».
Come mai?
«Mi piaceva la vita dei campi, aiutavo i contadini nel loro lavoro. Poi ricordo l’8 settembre, con i soldati che venivano a chiedere cibo e soprattutto vestiti, per potersi liberare delle divise».
Se avesse avuto qualche anno in più, avrebbe scelto la Repubblica sociale o i partigiani?
«Nessuno dei due fronti».
Perché decise di fare il sacerdote?
«Sono sempre stato credente e praticante. Quando stavo finendo il liceo scientifico, il mio direttore spirituale mi chiese molto delicatamente se avessi pensato anche alla possibilità di farmi sacerdote. La proposta mi piacque, e dissi di sì quasi d’istinto. Dedicarmi a Dio mi apparve qualcosa di entusiasmante».
Ma la sua famiglia non era d’accordo, vero?
«Mio padre e mia madre erano molto contrari. Favorevole invece era mia sorella Donata, allora una ragazzina di dodici anni, che mi ha poi sostenuto, anche economicamente, per tutta la sua vita».
Una volta lei confidò al Corriere di essersi innamorato. Ci racconta qualcosa di più? Le pesò rinunciare a quell’amore?
«Per la verità, mi sono innamorato o, forse meglio, mi sono sentito attratto da una donna più di una volta. Ma con l’aiuto di Dio ho sempre resistito. Naturalmente quelle rinunce mi pesavano. Ma non presi mai in considerazione l’ipotesi di una scelta diversa. Non ho mai pensato di lasciare il sacerdozio».
Se le ricorda, quelle donne?
«Certo. Almeno tre o quattro, in diversi periodi. La vita è lunga…».
È vero che da giovane era un prete progressista, conciliare?
«Ero certo entusiasta del Concilio; e lo sono ancora. Quando però, dopo il Concilio, si aprì la crisi che è arrivata a mettere in discussione i dogmi della fede cattolica, ho reagito immediatamente, opponendomi con forza».
Quali dogmi?
«Addirittura la divinità di Cristo. Per non dire della morale sessuale. Fu un periodo molto particolare».
Pensa che il Concilio sia andato oltre le intenzioni di Giovanni XXIII e Paolo VI?
«No, assolutamente. Come le ho detto, non bisogna confondere Concilio e dopo-Concilio».
Come ricorda il primo incontro con Papa Wojtyla?
«Era l’autunno del 1984, ed ero vescovo ausiliare a Reggio Emilia. Ma ero anche uno dei tre vicepresidenti del comitato preparatorio del convegno ecclesiale di Loreto. Un pomeriggio ricevetti una telefonata da monsignor Re, allora assessore della segreteria di Stato, che mi comunicava che ero atteso assieme a lui a cena dal Papa. Giovanni Paolo II entrò subito in merito, chiedendomi notizie e valutazioni sulla preparazione del convegno. Ho risposto con totale franchezza, e mi sono reso conto che il Papa apprezzava questa mia schiettezza e le mie valutazioni. Da allora mi chiamò spesso e ho goduto della sua fiducia».
Che cosa aveva detto al Papa?
«Avevo criticato l’impostazione della Cei. La Conferenza dei vescovi pensava che il mondo fosse ormai secolarizzato. Giovanni Paolo II era invece convinto che la secolarizzazione fosse in via di superamento, e occorresse una nuova evangelizzazione, rivolta ai popoli già cristiani che erano a rischio di perdere la fede. Io pensavo con il Papa che si potesse tenere le nostre posizioni e fare un’opera di evangelizzazione».
E sul comunismo?
«Giovanni Paolo II era contrario al compromesso storico. Per lui, i cristiani che sul comunismo non ragionavano in termini di “noi” e “loro” non avevano capito».
Com’è stato davvero il suo rapporto con Prodi?
«Con Prodi e con la sua grande famiglia sono stato molto amico. Tanto da celebrare il suo matrimonio con Flavia Franzoni. Le nostre strade si sono divise quando intorno al 1990 io sono rimasto su posizioni di centro, mentre lui si è orientato a sinistra. Con il senno di poi, penso che entrambi, sia io sia Prodi, avevamo frainteso le posizioni dell’altro, ritenendole coincidenti con le proprie. Mentre non era vero. Oggi i nostri rapporti sono decisamente buoni, anche se non ci sentiamo spesso».
E il rapporto con Berlusconi?
«L’ho conosciuto quando è “sceso in campo”, per usare il suo linguaggio. Mi resi subito conto che il suo stile di vita aveva aspetti problematici. Ma la sua azione politica mi è apparsa decisiva per fermare il comunismo, per introdurre il bipolarismo in Italia e per resistere all’ondata di laicismo che già allora minacciava valori non negoziabili per la Chiesa».
Nel 1994 i comunisti non c’erano quasi più.
«Dica pure post-comunisti, se preferisce. Resta il fatto che, se non c’era Berlusconi, al potere andava Occhetto».
E lo stile di vita?
«Ricordo che noi cattolici ci infervorammo per John Kennedy; e venne fuori che neanche lui era irreprensibile».
È pentito di aver in qualche modo dato un avallo, con la sua autorevolezza, alla stagione di Berlusconi? O rifarebbe quella scelta?
«Non sono pentito. Oggi la situazione è diversa. Posso solo dire che i miei orientamenti di fondo non sono cambiati».
Qual è stato il più grande Papa che la Chiesa ha avuto in questi 95 anni?
«Domanda difficile. Per la Chiesa è un periodo fortunato, in cui si sono succeduti vari grandi Pontefici. Penso a Pio XII, a Giovanni XXIII, a Paolo VI, a Giovanni Paolo II, a Benedetto XVI».
Deve scegliere.
«Per me il maggiore è Giovanni Paolo II».
Perché?
«Perché fu un vero leader mondiale».
Benedetto XVI è stato più grande come teologo che come pontefice? Sapeva governare?
«È stato soprattutto un grandissimo teologo. Il governo è stato il suo punto debole».
Lei fu uno dei protagonisti del conclave del 2005: emerse mai un’alternativa reale a Ratzinger?
«Sui conclavi vige il segreto. Dirò soltanto che reali alternative a mio parere non emersero».
Quale ricordo personale custodisce di quel conclave?
«Un’atmosfera positiva, fiduciosa. Eravamo reduci dal funerale di Giovanni Paolo II, che fu l’apogeo del prestigio della Chiesa. E poi ricordo il giuramento nella Sistina: “Giuro su Cristo che mi giudicherà…”. Dire quelle parole così impegnative sotto lo sguardo del Cristo giudicante di Michelangelo dava una scossa che ricordo ancora adesso».
Come visse le dimissioni di Ratzinger?
«Mi hanno totalmente sorpreso, e mi dispiacquero molto».
Fu un errore?
«Le dico la verità: fu una decisione sbagliata, almeno a me pare così. Poi certo lui sapeva meglio di me quali erano le sue condizioni, quindi non voglio giudicare. A me le dimissioni non convinsero».
Sul comò di fronte vedo le foto di Wojtyla, di Ratzinger, di Prevost; non vedo quella di Bergoglio.
«Si giri. È lì, alle sue spalle».
Papa Francesco l’ha delusa?
«Con papa Francesco mi sono trovato in difficoltà. Troppo grande e improvviso è stato il cambiamento. Più che deluso, sono stato sorpreso».
Quale bilancio fa del suo pontificato? Ha fatto più bene o più male alla Chiesa?
«Mi sembra un bilancio complesso, con aspetti molto positivi e altri assai meno. È presto per giudicare quali di essi prevalgano».
Mi dica una cosa positiva di Francesco.
«Il suo grande coraggio».
E una cosa negativa.
«Tenere troppo poco conto della tradizione. Non a caso è stato forse più amato dai non credenti che dai credenti».
E Leone che impressione le fa? L’ha incontrato?
«Mi ha concesso un’udienza nei primissimi giorni del pontificato. La mia impressione è ottima. Sono felice di avere questo Papa».
Oggi alla guida della Cei, che lei ha retto per sedici anni, c’è un cardinale considerato progressista. I vescovi italiani sono troppo «a sinistra?».
«Non mi pare che l’episcopato italiano nel suo complesso possa dirsi a sinistra. Le posizioni sono diversificate, come è sempre stato e come è naturale che sia. Era così anche ai miei tempi».
Lei una volta disse al Corriere: la cultura è a sinistra, ma il Paese è a destra. Come mai questa dicotomia secondo lei?
«È una dicotomia che esiste in molti Paesi, non solo in Italia. Deriva probabilmente dal fatto che la gente comune dà più peso agli aspetti pratici, mentre gli intellettuali guardano a questioni che ritengono di principio».
Che giudizio politico e personale dà di Giorgia Meloni?
«Decisamente positivo sotto entrambi gli aspetti, sia politico sia personale».
La conosce? Vi parlate?
«La conosco da molti anni e parliamo volentieri, nei limiti del suo tempo. È una persona molto immediata, molto schietta. Con me è anche molto affettuosa. C’è un’amicizia vera, ci mandiamo sempre a salutare».
In che modo?
«L’infermiere che viene da me per curarmi va anche da lei».
Di Trump cosa pensa?
«Ho un giudizio non positivo. Trump ha sconvolto la politica americana e mondiale, andando in una direzione molto discutibile. E poi non mi piace la sua spregiudicatezza».
Lei tornerebbe alla messa in latino?
«Certamente no. È molto importante che la gente comprenda il linguaggio nel quale si celebra».
Però la considerano un tradizionalista.
«Tradizione non vuol dire tornare indietro. Al contrario. “tradere” significa passare da una mano all’altra. Tradizione è la continuità della Chiesa».
La Chiesa ha rinunciato a parlare di quelli che si chiamavano valori non negoziabili? La sacralità della vita, l’indissolubilità del matrimonio, la morale sessuale?
«Non possiamo rinunciare a parlare di questi valori. Fanno parte del contenuto della nostra fede, dell’etica cristiana. Oggi se ne parla meno di prima; ma questa è una lacuna a cui dobbiamo porre rimedio».
Nel Vangelo secondo Luca, Gesù chiede: «Quando il figlio dell’uomo tornerà, troverà la fede sulla terra?». Lei cosa risponderebbe a questa domanda?
«Risponderei: “Signore, tu lo sai; io lo spero con tutto il cuore”».
Ma quando tornerà Cristo secondo lei?
«Anche questo lo sa soltanto Dio».
Quindi non è certo che troverà ancora la fede sulla terra?
«Purtroppo no».
Il cristianesimo è in crisi? Come vede il suo futuro?
«Almeno in Occidente la crisi della fede è innegabile. E la nostra prima risposta deve essere la preghiera. Tanta preghiera, affinché la luce della fede non si spenga ma prenda nuovo vigore. Sul futuro a lungo termine del cristianesimo, sono comunque ottimista».
Perché?
«Perché alla sua origine non c’è soltanto l’uomo. C’è Dio».
Esiste nel mondo un sentimento anticristiano?
«Esiste certamente, ed è esistito nelle forme più varie fin dall’inizio del cristianesimo. Ricordiamo la parola di Gesù: “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”. Colpisce la scarsa solidarietà di noi credenti verso i nostri fratelli perseguitati».
Le chiese sono sempre più vuote, ma la gente ha un disperato bisogno di speranza e di fede. Come spiega questa contraddizione?
«È una contraddizione più apparente che reale. Coloro che hanno perso la fede non per questo non hanno più bisogno di speranza, e anche di fede. È un buco che non si può chiudere, e che testimonia che siamo fatti per Dio. Poi influiscono le carenze di noi credenti nell’opera di evangelizzazione».
Anche i seminari sono vuoti. Non è crudele imporre ai preti di non avere una famiglia?
«Non si tratta di un’imposizione, ma di una condizione liberamente accettata. Il celibato dei preti ha i suoi problemi, ma anche i suoi vantaggi. A mio parere, molto maggiori».
Perché una donna non potrebbe fare il sacerdote?
«La Chiesa non può ordinare le donne sacerdoti, perché il sacerdote è configurato a Cristo, che è di sesso maschile».
Lei ha paura della morte?
«Sì. Soprattutto perché alla morte segue il giudizio di Dio sulla nostra vita. La paura è attenuata dalla fiducia nella misericordia di Dio, che è infinita».
Quindi è possibile che l’inferno sia vuoto?
«Non ci credo. Temo che l’inferno vuoto non lo sia affatto».
Ha mai dubitato dell’esistenza di Dio, della resurrezione della carne?
«Dubitato in senso proprio, no. Altra cosa è la tentazione. Di tentazioni riguardo alla fede ne ho avute tante, anche forti».
Ma cosa accade al nostro corpo tra la morte e la resurrezione nel giorno del Giudizio Universale?
«Il nostro corpo giace nel sepolcro, in attesa di risorgere per la salvezza eterna o per la condanna. La nostra anima immortale è invece già in paradiso, o all’inferno o in purgatorio. Il giudizio particolare su ciascuno di noi avviene già al momento della morte».
Lei ha scritto sull’aldilà un libro bellissimo, che però non dà certezze. Ad esempio c’è un capitolo in cui rievoca le esperienze premorte — la luce dopo il tunnel, la sensazione di beatitudine… — ma poi conclude: queste persone non sono realmente morte, quindi il loro racconto non è decisivo. Cosa dobbiamo aspettarci allora?
«Vorrei precisare: nel mio libro riconosco che la ragione da sola non ci dà certezze sull’aldilà; ma dico chiaramente che questa certezza la possiamo raggiungere attraverso la fede».
Ma lei personalmente l’aldilà come lo immagina?
«L’aldilà per coloro che si salvano è la visione di Dio, l’unione immediata con Lui. Oltre che l’unione con i nostri fratelli defunti. I vangeli impiegano al riguardo immagini molto belle; ad esempio quella del convito. Un banchetto solenne, in cui mangiamo insieme e insieme siamo felici. Mantenendo la nostra individualità».
Lei è stato presidente della Commissione su Medjugorje. Che idea si è fatto?
«Per la nostra Commissione le prime sette apparizioni furono reali. Era davvero la Madonna. Dopo le cose si confondono, e non abbiamo dato un giudizio preciso. Se siano apparizioni o suggestioni non lo so».
Qual è la persona più intelligente che ha conosciuto nella sua vita?
«Non mi sento in grado di giudicare in merito. Posso dire che di persone estremamente intelligenti ne ho conosciute non poche. Ad esempio Giovanni Paolo II, o in maniera diversa il mio professore di teologia alla Gregoriana, Bernard Lonergan».
Wojtyla era così intelligente?
«Pensi che leggeva due libri contemporaneamente: il più difficile di persona, mentre si faceva leggere a voce alta il libro più facile. San Tommaso d’Aquino invece dettava due libri contemporaneamente».
E la persona più buona?
«A maggior ragione non mi sento di giudicare. Anche di persone buone ne ho conosciute molte. Mi limito a ricordarne due che sono addirittura sante: madre Teresa di Calcutta e Giovanni Paolo II».
Lui dubbi non ne aveva.
«No, lui no. Una fede granitica. Quando pregava, era davvero a colloquio con Dio».
corriere.it